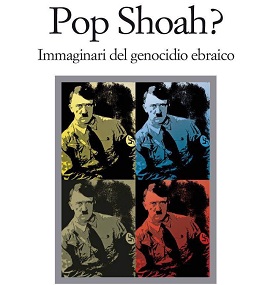temi e problemiscuola e cittadinanza
Genealogia della “Pop Shoah”
Per la Giornata della memoria, la mia scuola si è portata avanti con il lavoro e giusto la settimana scorsa, in scaglioni composti e ordinati, tutte le classi dell’istituto sono andate ad assistere a una rappresentazione teatrale. L’imbeccata veniva da un collega appassionato di teatro del Dipartimento di storia e filosofia, a cui “per ufficio” spetta di proporre iniziative per la ricorrenza. In mancanza di controproposte, si è convenuto di andarci. Si trattava della storia di un gruppo di militari italiani, internati in Germania nel settembre del 1943. Spettacolo davvero ben fatto, persino “commovente”, stando al telegrafico commento carpito a un mio allievo. Eppure, mentre rientravo in istituto con un senso di sollievo familiare – “Anche per quest’anno è andata, il prossimo si vedrà!” – non riuscivo a soffocare un non meno familiare senso di disagio: in fin dei conti, se al posto dei militari italiani ci fossero stati, poniamo, Anne Frank o Guido Orefice de La vita è bella, forse non ce ne saremmo quasi accorti, senza mancare beninteso di commuoverci altrettanto.
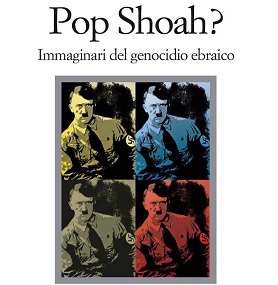 A intercettare il mio disagio, vi è ora il volume collettaneo curato da Claudio Vercelli e Francesca R. Recchia Luciani, Pop Shoah? Immaginari del genocidio ebraico, Il Melangolo, Genova, 2015, che raccoglie gli atti del quarto convegno sulla didattica della Shoah, organizzato dall’Università di Bari. La tesi di fondo è che negli ultimi trenta/quarant’anni la Shoah si sarebbe trasformata in fenomeno pop e ci si interroga da differenti punti di vista su ragioni, forme e conseguenze di tale trasformazione. Da quando la memoria della Shoah è «un elemento costitutivo della cittadinanza democratica, linea divisoria tra civiltà e barbarie», il suo racconto, la costruzione di un immaginario collettivo a essa legato, si sarebbero gradualmente sganciati dalla materialità degli eventi storici che l’hanno prodotta, acquisendo una fisionomia culturale autonoma e un valore paradigmatico («metonimia del male assoluto», modello di una condizione universale: la vittima indifesa), approdando a una «pedagogia pubblica, che ruota intorno a diversi usi della storia e della memoria» e che si nutre di «linguaggi, simbolismi, retoriche», «narrazioni, grammatiche, stilemi, agende di priorità» offerti senza posa dai mezzi di comunicazione. In tal modo, il ricordo della Shoah non sarebbe più appannaggio degli esperti o dei testimoni e dei loro eredi ma «dell’ambito tutto essoterico della comunicazione e dello spettacolo» [1].
A intercettare il mio disagio, vi è ora il volume collettaneo curato da Claudio Vercelli e Francesca R. Recchia Luciani, Pop Shoah? Immaginari del genocidio ebraico, Il Melangolo, Genova, 2015, che raccoglie gli atti del quarto convegno sulla didattica della Shoah, organizzato dall’Università di Bari. La tesi di fondo è che negli ultimi trenta/quarant’anni la Shoah si sarebbe trasformata in fenomeno pop e ci si interroga da differenti punti di vista su ragioni, forme e conseguenze di tale trasformazione. Da quando la memoria della Shoah è «un elemento costitutivo della cittadinanza democratica, linea divisoria tra civiltà e barbarie», il suo racconto, la costruzione di un immaginario collettivo a essa legato, si sarebbero gradualmente sganciati dalla materialità degli eventi storici che l’hanno prodotta, acquisendo una fisionomia culturale autonoma e un valore paradigmatico («metonimia del male assoluto», modello di una condizione universale: la vittima indifesa), approdando a una «pedagogia pubblica, che ruota intorno a diversi usi della storia e della memoria» e che si nutre di «linguaggi, simbolismi, retoriche», «narrazioni, grammatiche, stilemi, agende di priorità» offerti senza posa dai mezzi di comunicazione. In tal modo, il ricordo della Shoah non sarebbe più appannaggio degli esperti o dei testimoni e dei loro eredi ma «dell’ambito tutto essoterico della comunicazione e dello spettacolo» [1].
La consegna della Shoah, della definizione del patrimonio culturale che essa rappresenta, alle logiche comunicative dei media (trasfigurazioni simboliche, slittamenti semantici, comparazioni e sovrapposizioni improprie, quella generale intercambiabilità e riproducibilità che è loro propria), se, da un lato, contribuisce a sacralizzarla, a trasfigurarla in mito, dall’altro, finisce per banalizzarla, per svilirne «irreparabilmente la veracità»: «se Auschwitz è ovunque ed è il tutto, il rischio è che sia anche in nessun luogo e si riduca al nulla»[2]. Di fronte a ciò, ripristinare «il valore ermeneutico della Shoah» messo in crisi dalla sua “mediatizzazione” è «l’urgenza epistemologica» che giustifica il volume, oggi avvertita «non solo da chi si occupa di storia ma anche da chi si occupa di didattica, di filosofia, di estetica, di mass media, di studi culturali»[3].
Per darne un’idea di insieme, si può dire che questo volume è una genealogia complessiva della Pop Shoah, di cui ogni saggio analizza un aspetto, intraprende uno specifico “scavo”. È impossibile qui restituire in dettaglio la pluralità di piani che lo compongono. Mi limito a qualche esempio: vi è una genealogia politica, che la riconduce alla crisi più generale del “politico”, al «declino della sfera dell’agire pubblico», «mito unificante» che nei contesti nazionali rimpiazza o surroga il paradigma dell’antifascismo, nel contesto euroamericano riempie il vuoto provocato dalla caduta del Muro[4]. Vi è una genealogia didattica, che analizza le ragioni del successo scolastico della Shoah – «la carica emotiva», «l’acquisita rilevanza mondiale», «la pervasività», non da ultimo, l’istituzionalizzazione del Giorno della memoria – e l’impatto «antididattico» che ha esercitato e continua a esercitare sulla scuola– la rottura dell’equilibrio precario tra la storia e l’insegnamento della storia, in nome di una memoria decontestualizzata e toccante, appaltata ad agenzie formative ben altrimenti attrezzate e agguerrite [5]. Vi è una genealogia cinematografica, che mostra l’assoluta centralità di Schindler’s List nella sua trasformazione in fenomeno pop [6]. Vi è l’analisi dei meccanismi che l’hanno a poco a poco trasformata in un oggetto di spettacolo e di consumo[7], dei modi in cui la cultura pop funziona e se ne appropria: di come l’immagine della bambina dal cappottino rosso del film di Spielberg si sia potuta trasformare in un’autobiografia apocrifa, in un gruppo Facebook o nell’abito di scena di una pattinatrice russa che danza sulle note della sua colonna sonora [8]; di come i viaggi della memoria, rigorosamente nei mesi di gennaio/febbraio, finiscano per condurre le scolaresche più che sui luoghi sui set cinematografici dell’orrore [9]; di come l’indicibile di una ragazzina di sedici anni che muore di tifo a Bergen-Belsen si sia potuto trasformare in un’icona della gioia di vivere, in un inno alla vita su scala planetaria [10]. E vi è molto altro ancora, che invito il lettore a cercare.
Opera dichiarata di «decostruzione dell’industria della memoria», Pop Shoah? sembra nondimeno attraversata da un’oscillazione linguistica, probabile sintomo di una tensione culturale più profonda, forse persino generazionale. Da un lato, ricorre l’espressione «mezzi di comunicazione di massa», «mass media»: che fa pensare alla Scuola di Francoforte e ai media come un dispositivo egemonico “esterno” da cui difendersi, da arginare; dall’altro, è non meno ricorrente l’espressione «condizione postmediale» [11], che li interpreta come un paesaggio infinitamente più mobile, aperto e transitorio e insieme, infinitamente più pervasivo. Da un lato, si tenderà, per così dire, a far pesare le ragioni della storia; dall’altro, le ragioni dell’immaginario, o, meglio, a capire «come tenere insieme la consapevolezza della realtà storica cui ci si riferisce con il suo uso metaforico, simbolico o paradigmatico»[12]. In qualche modo, i saggi di questo volume si collocano in un punto qualunque di questo (dis)continuum.
Provo a chiudere con uno sguardo “alto” sul pop. In una nota videointervista del 1982 [13], invitato da Wim Wenders a esprimersi sul futuro del cinema, Michelangelo Antonioni osservava en passant: «è molto difficile parlare di quello che sarà l’avvenire … Avremo il cinema in casa, non avremo più bisogno delle sale cinematografiche. Tutte le strutture esistenti dovranno cadere e non sarà facile, né sarà una cosa breve. Però tutta questa trasformazione, tutti questi mutamenti avverranno e noi non potremo farci niente ... ci resterà soltanto una cosa da fare: quella di adattarci … alle nuove tecnologie, alle nuove atmosfere impure che domani dovremo respirare … probabilmente anche il nostro organismo cambierà … chissà dove, come andremo a finire. Non lo so. E’ molto probabile che il futuro si presenti con una ferocia che al giorno d’oggi non c’è ancora, per quanto ormai si può già presentire quello che sarà» [14].
Ecco, Pop Shoah? è un tentativo di fare i conti con un futuro che si presenta nella sua ferocia, di cui, verosimilmente, quella tensione è parte integrante.
Note
1. Da C. Vercelli, F.R. Recchia Luciani, Pop Shoah? Immaginari e pratiche collettive intorno all’uso pubblico della memoria dello sterminio degli ebrei d’Europa, Il Melangolo, Genova, 2015.
2. Ibidem.
3. Ibidem.
4.C. Vercelli, "Sentimento e inazione. Alcune note di discussione sull’immaginario del genocidio nell’età dell’impolitico", idem, pp. 172-185.
5. A. Brusa, "La terra di nessuno fra storia, memoria e insegnamento della storia. Didattica e non didattica della Shoah", idem, pp. 30-16.
6. C. Gaetani, "Riconosco ergo Pop", idem, pp. 60-70.
7. F. R. Recchia Luciani, "Shoah Show: il genocidio come oggetto culturale tra mediatizzazione e consumo", idem, pp. 143-157.
8. D. Garofalo, "Red Coat Reloaded. Schndler’s List. L’immaginario della Shoah e la cultura pop", idem, pp. 71-86.
9. B. Maida, "I viaggi della memoria nell’esperienza italiana", idem, pp. 102-111.
10. F. Loiacono, "Anne Frank: dalla vita interrotta al simbolo pop", idem, pp. 87-101.
11. R. Eugeni, La condizione postmediale. Media, linguaggi e narrazioni, La Scuola, Brescia, 2015.
12. G. Schwarz, "La Shoah come paradigma: memoria dell’evento e paragoni (im)possibili", idem, pp. 158-171.
13. Chambre 666: in occasione del festival di Cannes del 1982, Wim Wenders preparò una macchina da presa fissa in una camera d'albergo e invitò una serie di registi a entrarvi da soli, per rispondere a una serie di domande sul futuro del cinema e in particolare: "Il cinema è un linguaggio che andrà perduto, un'arte che sta per morire?". Tra gli intervistati, oltre a Antonioni, Herzog, Fassbinder, Spielberg, Godard, lo stesso Wenders.
14. Cfr. Chambre 666.